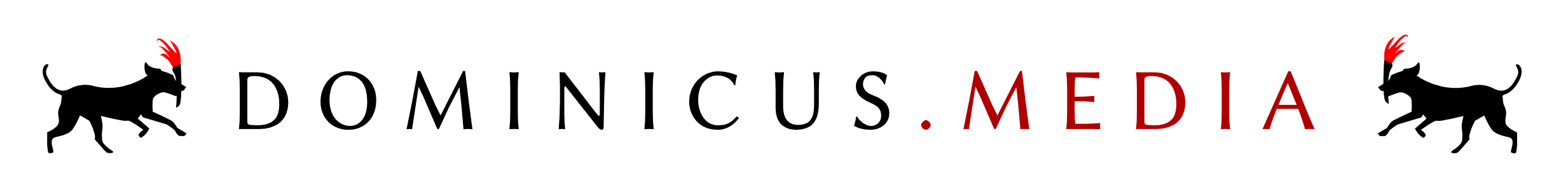Direttore responsabile
“Qualcuno dirà: perché essere qui?
Don Andrea Santoro, lettera da Urfa – Harran 27 aprile 2001
Non per convertire appunto, ma per convertirsi,
cambiando il nostro cuore e i nostri pensieri,
a contatto con le nostre radici cristiane
e con un mondo che ha poco
ma tanto nello stesso tempo”
La prima volta che lessi questa frase di don Andrea Santoro,1 ero nella mia cella del convento di Bologna, dove avevo iniziato da poco lo studentato. Con la spocchia e la incoscienza dei neofiti, mi permisi di giudicare quella frase, senza comprenderne il senso. Quella frase fa parte di una lettera che don Andrea scrisse dalla Turchia il 27 aprile 2001, qualche mese dopo il suo arrivo. Mi sono trovato a rileggerla, più o meno a un anno dal mio arrivo nella stessa terra e mi sono reso conto di quanto il mio giudizio fosse affrettato, sciocco e meschino. Aveva ragione, don Andrea, anzi, ha ragione don Andrea. In questo periodo ho ripreso in mano il volume delle “Lettere dalla Turchia” che già avevo presentato sull’Osservatore Domenicano (link) ma, spero di non essere lo stesso stolto e giudicante lettore di cinque anni fa: se rileggo oggi queste parole mi coglie la dolorosa sensazione di non aver nemmeno iniziato a convertirmi.
Oggi quella frase sarei pronto a sottoscriverla senza indugio e, in particolare, questo tempo di Avvento, di vigilante attesa, sembra creare un clima in cui le parole di don Andrea mi paiono risuonare in maniera più acuta e penetrante. In quest’anno mi sono successe tante cose: ho incontrato molte persone, ho visitato molti luoghi. Sono stato a fare un mese di servizio proprio nella parrocchia che fu di don Andrea, a Trabzon, sulle rive del mar Nero. Sull’ultima panca della chiesa di santa Maria, c’è ancora il segno di uno dei proiettili che uccise don Andrea il 5 febbraio del 2006. Ho celebrato la santa messa e ho (poveramente) predicato dove don Andrea ha celebrato la santa messa e ha predicato. Ho esplorato la città, ho conosciuto le famiglie della zona, ho condiviso un periodo di grande grazia con la comunità delle suore che mandano avanti la chiesa (Servidoras, sono il ramo femminile dell’Istituto del Verbo Incarnato). La nostra giornata era scandita dal lavoro, dalla preghiera, dall’adorazione eucaristica (ogni mattina alle 6,30) e da tanti momenti di condivisione con la “nostra” comunità, a partire dal rosario, guidato dai bambini della parrocchia, che precede la messa feriale. All’interno della casa c’è un piccolo laboratorio, dove alcune donne iraniane confezionano le ostie per la messa. Era molto emozionante, ogni giorno, consacrare quel pane, frutto della terra e del loro lavoro, al nostro amore più grande. Anche le suore, in un altro piccolo laboratorio, producono dei servizi per la messa (purificatoi, manutergi, corporali e palle). L’amore per la messa e per l’Eucaristia mi è perso davvero un legame molto forte in una comunità, tuttavia, non certo priva di problemi, come le difficili relazioni fra i diversi gruppi che la compongono. Luci e ombre, come avviene ovunque, ma certamente questo è stato il periodo più felice della mia permanenza in Turchia. Di quell’esperienza mi mancano molte cose, forse perché è qui, sulle rive del Mar Nero, nella terra che, secondo la tradizione ha visto il passaggio di sant’Andrea (qui molto venerato) e di san Pietro stesso, che ho davvero iniziato ad aprire il cuore e gli occhi sulla Turchia e sul mio stesso essere sacerdote, scoprendomi anche in questo caso, povero e bisognoso di convertirmi continuamente.
L’esperienza nelle terre di antichissima storia cristiana che mi ha fatto comprendere le parole di don Andrea Santoro
Un’altra esperienza che mi ha molto aiutato a comprendere quelle parole che, prima, pretendevo stupidamente di giudicare e di misurare, è stato il viaggio – pellegrinaggio nella regione del Tur Abdin, nel sud est della Turchia, dove il vescovo di Iskenderun, mons. Paolo Bizzeti ci ha fatto da guida. Siamo stati a Mardin, una città molto importante per i siriaco cattolici. Mardin si trova fra il Tigri e l’Eufrate. La città ci accoglie con la sua storia, i suoi colori, particolarmente caratteristico il giallo ocra delle costruzioni, i suoi monasteri, come quello detto “dello zafferano”, che risale al V secolo dopo Cristo. Anche Mydiat è un luogo in cui veramente si coglie il senso di una storia, anzi, della Storia: da queste parti si trova l’antichissimo monastero di Mor Gabriel (ossia san Gabriele), che nel VI secolo aveva più di mille monaci e che costituì, a lungo un importantissimo luogo di studio e di diffusione culturale, grazie anche a una vastissima biblioteca di cui restano solo le antiche testimonianze. Siamo stati a pochi chilometri da Harran, il villaggio da cui partì il nostro padre nella fede Abramo e dove lo stesso don Andrea trascorse una parte della sua missione fidei donum in Turchia. Abbiamo sfiorato l’inizio della via della seta, che mi ha fatto tornare bambino quando sognavo al sentire le storie scritte da Marco Polo. Siamo stati nei monasteri siriaci ortodossi, dove siamo stati accolti come fratelli, dove più che a parole, mi è parso che potessimo intenderci perfettamente negli sguardi o nei silenzi che punteggiavano le nostre complicate conversazioni. Siamo stati nel monastero di Mor Augin, fondato secondo la tradizione, da san Pacomio e qui, abbiamo avuto l’occasione di meditare sulla vita aspra di questi nostri fratelli, di cui forse non sapremmo imitarne l’esistenza per più di qualche giorno, ma che per certi versi abbiamo invidiato. I monasteri siriaci hanno una caratteristica in comune (in realtà più di una, ma questa mi ha particolarmente colpito, anche fisicamente), le porte sono molto basse e occorre chinarsi oppure rassegnarsi ad un continuo confronto fra la durezza della propria testa e quella delle spesse mura del monastero (ovviamente vincono sempre queste ultime). Anche quell’esperienza parla di conversione: una conversione all’umiltà, alla piccolezza, al raccoglimento e all’attenzione. Non solo ci dobbiamo convertire con l’anima e il cuore, ma anche con il corpo.
Abbiamo celebrato insieme la messa in un antico caravanserraglio, dove eravamo i soli cristiani, ma nessuno ci ha molestato, e non solo per la nostra grande discrezione. Abbiamo pregato e celebrato la messa in chiese antichissime, alcune delle quali conservate solo all’opera nascosta e silenziosa di intere famiglie e di monaci che, alla cura di queste piccole chiese, dedicano tutta la loro vita, riuscendo ad essere, allo stesso tempo, nella più grande precarietà e a lavorare per le prossime mille generazioni. Quelle piccole chiese domestiche sono come quelle in cui la Chiesa stessa è nata e continua a vivere.
Don Andrea aveva colto l’importanza di queste piccole comunità che sanno parlare: “il linguaggio della preghiera, dell’amore di Dio, del lavoro quotidiano, dell’amore vissuto in fraternità, della bontà spicciola verso tutti, dell’amicizia semplice e generosa verso i vicini, dell’umile dialogo quotidiano, della testimonianza vera e trasparente di Colui che abita nei nostri cuori”.2
Dalla terrazza del monastero di Mor Yakup lo sguardo abbraccia la Mesopotamia, si vedono l’Iran, l’Iraq e una propaggine della Siria. Il silenzio è assoluto. Si vive molto semplicemente, avendo lo stretto indispensabile, e non sempre: siamo accolti per il pranzo da una famiglia molto numerosa che, probabilmente mette in tavola quanto gli serve per qualche giorno, ma lo fanno con semplicità e amore.
Di fronte alla serenità dei monaci, che anche in condizioni proibitive, riescono a realizzare opere mirabili nei loro monasteri, tutte le difficoltà che mi pareva di aver trovato nella ricca Istanbul, scompaiono e rimane solo la mia miseria. Non sempre la conoscenza della lingua aiuta, la mia è ancora molto incipiente e a fatica ho superato l’esame del corso A1, ma c’è dell’altro, come sperimenta ognuno di noi che viene in questa terra: La nostra povertà ci obbliga a spezzettare il cibo della Parola, come se dovessimo imboccare dei bambini. Ma quei bambini siamo noi. Questo ci permette e ci obbliga di dire solo l’essenziale, quello che possiamo offrire.
È solo allora che riesco a capire quello che don Andrea scrive. Dalle sue lettere emerge spesso un’immagine su cui si fonda una vera e propria liturgia: la liturgia della porta. La porta, che sia quella di casa nostra, di un’umile famiglia del Tur Abdin o Trabzon, di un monastero, dell’anziana parrocchiana di Sen Piyer a cui, ogni settimana, porto la Comunione, è la metafora di una condizione. La nostra vita è uno stare sulla soglia. “è importante fermarsi” scriveva don Andrea, “entrare nelle porte che ti si aprono e tenere aperta la propria perché altri entrino”. E come è difficile superare quella soglia o lasciare che qualcun altro superi la nostra. Accogliere ed essere accolti, sono due aspetti diversi del vivere la nostra povertà che, spesso, almeno per quanto riguarda noi, solo in minima parte è quella materiale.
Le quattro parole di don Andrea
Ci sono quattro parole che don Andrea usa. Queste parole sono: aprire, sorridere, salutare, rispondere.3
Aprire
Aprire è il primo fondamentale gesto. La prima indispensabile tappa di un cammino di conversione. Non c’è conversione senza apertura. La chiusura in sé stessi, come dimostra la triste sterilità di tanto pensiero contemporaneo completamente introflesso attorno a un IO ipertrofico e arrogante, non permette di vedere altro che IO, non è generatrice: ha la sterilità della morte.
Sorridere
Dove non si arriva con le parole, si arriva con il sorriso. Quello lo capiscono veramente tutti. I turchi, poi, sono molto cordiali e, conditi da un sorriso, accettano volentieri anche i miei errori e le mie sgrammaticature, quando cerco di presentare loro qualche elemento della nostra chiesa, nei giorni di apertura. Nella maggior parte dei casi sono incontri che lasciano un buon profumo nel cuore. A volte capita l’interlocutore polemico, a volte provocatorio, ma quasi mai malevolo. Una volta un uomo, con cui avevo discusso a lungo, mi ha chiesto, quasi addolorato: “Lei è una brava persona, come è possibile che non sia musulmano?” e io con il mio poverissimo turco gli ho chiesto: “può succedere qualche cosa che Dio non voglia?”. Ci siamo lasciati con il sorriso e, in un certo senso, per entrambi è stata una piccola conversione. Io non sono diventato musulmano, ovviamente, né egli cristiano, ma abbiamo visto un fratello, ognuno nell’altro, non un diverso da “convertire” o “assimilare”. E non è poco. È Dio che converte i cuori, non dovremmo mai dimenticarlo.
Salutare
La terza parola è salutare. Sembra poco, ma in realtà è molto più di quanto pensiamo: l’ho imparato in questi mesi. A volte il mio povero turco mi consente poco più che questo, ma è sufficiente per accogliere ed essere accolto. In Turchia quando si va da qualche parte dove qualcuno sta lavorando, si saluta con un augurio “Kolay gelsin” sottintendendo quello che stai facendo “ti sia facile”, quando in Turchia ti accolgono lo fanno con un augurio: Hoş geldin, ossia benvenuto, a cui si risponde dicendo Hoş Bulduk, ossia mi sento ben trovato. E anche un buongiorno ha una sfumatura particolare. Qui in Turco si dice Gunaydın, che è più che un semplice buongiorno, ma l’augurio di un giorno luminoso.
Rispondere
L’ultima parola è rispondere. Rispondere non è semplice. Quando rispondiamo, che lo vogliamo o noi, diciamo chi siamo e in cosa e a chi crediamo. Anche rispondere, in un certo senso, è aprire una porta, quella del nostro cuore, a chi ci interroga, sia a quello che sono sinceramente desiderosi di conoscerci, sia a coloro, per fortuna pochi, che hanno fin da subito un atteggiamento polemico e di contrapposizione, ma anche questi ultimi, però, vengono a vedere la nostra chiesa e a fare domande. Se non se ne vanno avendo ricevuto risposte adeguate è solo colpa mia, che sono ancora lento, non solo nell’imparare il Turco, ma anche nel convertirmi, nel lasciare che Dio scalpelli il mio cuore di pietra, per mettere al suo posto un cuore di carne.
L’opposto della conversione: la frenesia che annega l’anima
Annota don Andrea che: “Nel servire Dio e nello stare in mezzo agli uomini a volte il cuore si riveste di una patina di durezza che si manifesta nell’asprezza, nella frettolosità e nell’assenza di un’intima partecipazione”.4 Questo può avvenire perché nelle nostre comunità la vita è molto impegnativa e, spesso, ci manca il tempo di rifiatare in questa settimana continuamente senza il sabato: le cose da fare sono talmente tante, spesso più delle nostre forze, che il parametro rischia di essere quello, così anche le nostre relazioni con i “laici” possono cadere sotto la tentazione di un certo funzionalismo, in cui noi e loro possiamo vedere l’altro solo in relazione a ciò che ci aspettiamo faccia per noi, nella misura in cui ci è utile o ci rende un servizio, vale per loro e vale anche per noi. Uno sguardo da contabile, a cui, a volte, nemmeno i nostri stessi confratelli riescono a sfuggire.
Anche in questo caso il nostro cuore ha bisogno di conversione, nell’accogliere l’altro, nel rispettare i suoi tempi, nel capire che se qualcosa è importante per lui, può, a volte deve, diventare importante anche per noi. È faticoso, è come sciogliersi come sale nell’acqua o come lievito nella pasta, ma è questo che siamo chiamati a essere gli uni per gli altri: lievito e sale. Spesso mi tornano in mente le parole di san Paolo, a cui sono molto affezionato, quando parla della debolezza. Nella seconda lettera ai Corinzi, scrive: “Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono debole è allora che sono forte”. 5 Scrive don Andrea che: “Il vantaggio di noi cristiani” è quello di credere “in un Dio inerme, in un Cristo che invita ad amare i nemici, a servire per essere “signori” della casa, a farsi ultimo per risultare primo, in un Vangelo che proibisce l’odio, l’ira, il giudizio, il dominio, in un Dio che si fa agnello e si lascia colpire”. 6
Le ultime parole di don Andrea
Don Andrea non lo sa ancora, ma queste sono alcune delle ultime parole che sta scrivendo, così come queste potrebbero essere fra le ultime mie (chi è che conosce il giorno e l’ora del suo incontro con il Signore?). Sono parole che, lette sotto questo cielo, sembrano risuonare più profondamente: “Quanti cristiani sono, non solo frastornati, ma nemmeno più guardano la croce? Non colgono più la sapienza, la forza, la vittoria della croce. Si sono convertiti alla spada: nella vita pubblica e in quella privata”.7 Si tratta di una conversione fin troppo semplice, basta farsi servi della superbia e dell’orgoglio, basta distogliere gli occhi e il cuore dalla croce per volgerla solo a sé stessi. Quanto mi dispiace vedere questo atteggiamento in cristiani che sono convinti di essere difensori della fede e della Tradizione (che ovviamente è solo quella che dicono e che piace a loro), senza rendersi conto di essere solo degli idolatri della loro superbia.
La conversione, invece, esige che accettiamo di morire a noi stessi, che ci disarmiamo, che ci riconciliamo con il nostro portare un tesoro in vasi di creta. 8 La conversione è il segno e la conseguenza di un’attesa. Si tratta di un’attesa che non è vaga e indefinita, perché l’evento centrale della nostra salvezza si è storicamente già compiuto, ma riguarda l’attesa che coltiviamo nel nostro cuore che implora: “Vieni Signore Gesù, vieni nel mio cuore, vieni nella mia vita”.
Siamo qui non per convertire, ma per convertirci è tutto questo: prima di tutto l’affidarci a Dio e non alle nostre forze, perché fare proselitismo per convertire è, inevitabilmente, scommettere tutto sulle proprie forze, sul proprio attivismo, sul proprio orgoglio mondano. Vuol dire avere uno spirito di conquista, di impossessamento che non è evangelico. Sono tutte cose che riempiono, anzi zavorrano le mani e il cuore. Solo se sapremo andare incontro al nostro fratello con le mani vuote per abbracciarlo, sapremo poi riempirle di frutti degni della nostra conversione.9
Riconoscimenti per le immagini
Foto di don Andrea Santoro da www.associazionedonandreasantoro.it; in filigrana: Mappa della Turchia, dalla Biblioteca del congresso americano e foto di Trazbon di Atakan Onur Selçuk.
- Don Andrea Santoro fu in Turchia come fidei donum dalla Diocesi di Roma dal 2000 al 2006. Fu ucciso a Trabzon il 5 febbraio di quell’anno, mentre era assorto in preghiera nella chiesa parrocchiale. Per approfondire la sua figura
- Don Andrea Santoro, lettera da Urfa – Harran del 30 maggio 2002
- Don Andrea Santoro, lettera da Trabzon/Urfa – Harran 3 novembre 2003
- Don Andrea Santoro, lettera da Trabzon, 18 maggio 2005
- 2Cor 12,10
- Don Andrea Santoro, lettera da Trabzon, 22 gennaio 2006
- Ibidem
- Cfr. 2Cor 4,7
- Cfr. Mt 3,8
Direttore responsabile